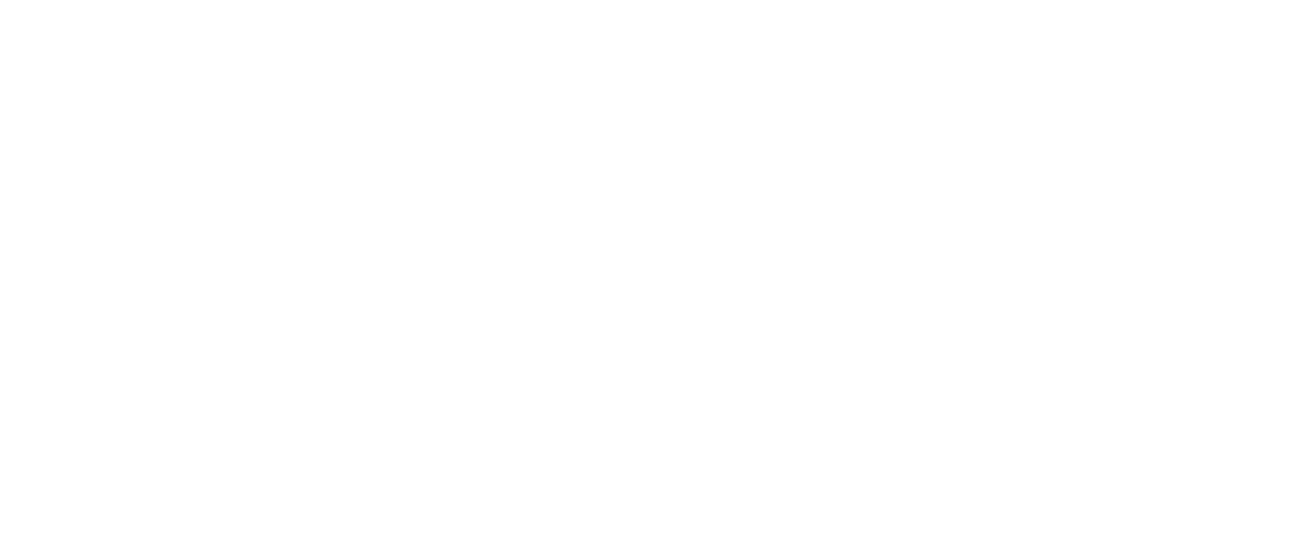Dopo aver vinto il Marco Zucchi Award a Locarno, Nella Colonia Penale è in concorso per il Premio Corso Salani al Trieste Film Festival. Per l’occasione abbiamo intervistato Gaetano Crivaro, autore del primo dei quattro corti che compongono il documentario, firmati anche da Silvia Perra, Ferruccio Goia, Alberto Diana, che hanno portato i loro occhi dentro uno dei luoghi più incogniti del problematico sistema carcerario italiano.
Come sta andando il passaggio del documentario nei festival? Che riscontro hai avuto rispetto a un tema così ostico e sconosciuto al grande pubblico, anche quello magari più “attento” dei festival?
Dopo Locarno il film ha avuto altri passaggi, ad esempio al Medfilm festival di Roma, e a breve usciremo anche in alcune sale della Sardegna, attente al territorio e a questo tipo di programmazione. Il tema di Nella colonia penale più che raro è proprio sconosciuto. Una delle principali reazioni dopo aver visto il film o dopo aver anche solo letto la sinossi è la domanda “Che cos’è una colonia penale”? Le persone tendono a pensare che si tratti di qualcosa di simile ad un campo di lavoro, ad un luogo di reclusione molto vicino a quello che si può intuire e invece ci sono varie tipologie di colonie penali. Quelle comunemente dette sono case di lavoro all’aperto: qui alcuni dei detenuti rinchiusi possono lavorare. Non tutti però lo fanno perché ci sono altri bracci in cui ci sono detenuti non atti a quel tipo di lavoro o perché sono soggetti considerati pericolosi per la società o hanno problemi di natura psichiatrica. Nel mio caso ho girato proprio nella colonia penale dove c’erano internati che non ho potuto filmare: l’unico modo per raccontarlo è stato mostrare gli scatoloni con le diciture che facevano riferimento a loro. Non se mi sono spiegato oppure ho divagato…
Sì, dicevi che il pubblico quindi non è molto preparato perché non conosce la funzione delle colonie penali e che i detenuti in determinate circostanze abbiano la possibilità di lavorare in quegli spazi…
Il film non punta il dito polemicamente, vuole anzi quasi accompagnare lo spettatore nell’attraversamento di questi luoghi. Certo, gli mostriamo degli indizi che si tratta pur sempre di una condizione di detenzione ma non poniamo l’accento su quanto sia giusta più o meno l’esistenza di una colonia penale. Capita allora spesso che il pubblico interpreti questi spazi sconfinati come una forma di libertà. Tutti e quattro i registi abbiamo convenuto sul fatto che per noi in realtà il paesaggio sia una gabbia perché al di là della sua vastità non puoi fruirlo veramente: sei veramente isolato, come si vede nella scena di un detenuto che dopo la scarcerazione non sa dove andare. Il detenuto può uscire dalla sua cella ma c’è sempre il controllore, il sorvegliante che ricorda che non si è liberi di agire a proprio piacimento. Come si vede nei primi quindici minuti del film sembra di stare in un’azienda agricola con normali braccianti ma, ad un certo punto, entra dal fuoricampo una guardia penitenziaria che svela come questo fuoricampo sia sempre presente, ci sia comunque questa forma di controllo sui corpi. Teoricamente ti stanno insegnando un lavoro ma non credo che uscire dal carcere e fare il pastore possa essere una forma di emancipazione rispetto alla società che abbiamo nel 2025. Quando abbiamo fatto le prime proiezioni nelle prigioni, ad esempio, abbiamo incontrato un detenuto che era stato in una colonia penale ma aveva chiesto di andare via perché quando era stato male la struttura ospedaliera era a chilometri di distanza
Tornando alla scelta che dicevi di far intervenire il fuoricampo non subito ma piano piano penso alla prima inquadratura del tuo corto, Isili: la macchina da presa fissa riprende di spalle queste persone sedute evidentemente su un camioncino. Non sappiamo ancora chi sono e cosa stanno facendo ma si può arguire che sono operai che vanno al lavoro. Come mai hai scelto questa introduzione magari, invece, di una più didascalica (che infatti comparirà soltanto alla fine del doc)?
È una bella domanda a cui è difficile rispondere. Questo è il mio modo di fare cinema perché con questa struttura narrativa permetto a chi guarda di non avere subito le spalle al muro, di non dirgli subito cosa avverrà fino alla fine del film. Lavorare sull’ambiguità di alcune situazioni mi permette di lasciare allo spettatore la possibilità di stare su questo bilico, su questo margine in cui farsi domande piuttosto che avere risposte pronte. Quei lavoratori che sembrano dentro un furgone in una situazione di caporalato portano comunque ad un contesto riconoscibile. Poi però ci si chiede se questa sia una vera forma di emancipazione. Stare fuori una barriera mi permette di esplicitare la mia posizione: io non sono un detenuto o un poliziotto, sono un autore che come il protagonista del racconto di Kafka entra nella colonia per vedere come funziona la macchina. Osservandola, però, non mi è permesso tutto, non sono potuto andare infatti in ogni luogo. C’è sempre qualcosa che si frappone tra e me i detenuti: una porta, una sbarra, una recinzione e questo mi ha permesso di giocare su questa ambivalenza tra ciò che si vede e ciò che non si vede, tra il fuoricampo e ciò che è oltre
A proposito di quello che dici, penso all’avviso straordinario nella fabbrica della mozzarelle che impone che “tutti i detenuti lavoranti devono usufruire del riposo settimanale (fisico, cioè in cella)”, come se la prigione fosse il mezzo per scappare dalla fatica del lavoro della colonia penale. È un sentimento che avvertivi con i lavoratori? Com’era il loro rapporto con il lavoro e la detenzione?
Guarda, non so in generale cosa convenga perché ogni caso è specifico. Ci sono persone che, come detto, hanno magari problemi sanitari o fisici e per loro l’accesso ai posti di cura è molto più complesso. Anche perché in Italia la prigione rimane un sistema fatto non per rieducare ma per reprimere dato che ti viene affibbiata un’etichetta addosso e quando esci non sarai mai redento. Quella scritta per me è paradossale perché dopo aver finito di lavorare da detenuto so comunque che dovrò tornare in cella. Si tratta di uno quei cortocircuiti tipicamente italiani, come il proibito fumare nei luoghi dove si sa che non è permesso, per rafforzare un divieto che è già evidente
Il doc ha richiesto tempi di lavorazione lunghissimi, come si vede dalle mascherine Covid-19: è stata un’anomalia produttiva o si è trattato di una conseguenza dovuta alla particolare situazione in cui avete girato?
Diciamo che è stato un mix di queste cose. Noi abbiamo cominciato a scrivere e lavorare il film nel 2020, in piena pandemia. Fino al 2022 nelle colonie penali non si potevano fare attività esterne e in più, dato che abbiamo lavorato in 4 colonie diverse, abbiamo avuto a che fare con 4 direttori diversi che vuol dire, essendo luoghi molto gerarchici, diverse linee di indirizzo. Abbiamo quindi avuto colonie più aperte e ospitali, mentre altre molto meno
Quella dove hai girato tu come si posizionava in questo spettro?
Io ho avuto più fortuna con un comandante che stava per andare in pensione e, dato che stava un po’ mollando, mi ha lasciato molto campo libero. Così sono potuto entrare molto in sintonia con il custode che sorvegliava la mia lavorazione e ho potuto avere molto spazio. Anche perché ogni mattina ero trasparente riguardo a come si sarebbero svolte le riprese e non ho mai fatto niente di nascosto ma tutto con le normali autorizzazioni. Io ho girato nel gennaio del 2022, Ferruccio Goia a Is Arenas nel luglio 2022, Silvia Perra è stata l’ultima a girare nel gennaio 2023 a Mamone (come si vede dalla neve), mentre l’Asinara dato che non è più colonia penale ha permesso ad Alberto Diana di girare in momenti diversi del 2022/2023. Quindi abbiamo finito di fare le riprese nel 2023 nonostante avessimo finito di scrivere il film nel 2020. Poi ognuno di noi ha montato il suo episodio e, infine, in una sessione di montaggio finale abbiamo fatto sparire qualcosa da ogni episodio per far in modo che il film rispettasse sì la cadenza episodica ma avesse comunque il respiro di un lavoro unico, con temi e dinamiche che ritornavano. In questo modo quattro anni passano velocemente
Cosa ti porti di questa lavorazione che, come hai appunto raccontato, è stato molto gerarchizzata rispetto ad altri tuoi lavori come ad esempio a Hey Boys o Good Buy Roma dove andavi a intervenire in comunità che comunque ti lasciavano entrare più facilmente?
Beh, comunque quelle comunità che dici hanno qualche analogia con quelle carcerarie di Nella colonia penale perché erano anche esse comunità chiuse. Ad esempio sia Good Buy Roma, uno dei miei primi lavori del 2011 su una caserma occupata di via del porto fluviale a Roma, o Hey Boys hanno qualcosa in comune ma anche una grossa differenza rispetto al carcere. Il carcere ovviamente, a meno che tu compia qualche reato o vada a girarci, è un luogo impermeabile all’esterno e questa cosa viene sottolineata dal fatto che quando si entra tu debba lasciare il tuo cellulare, il tuo documento d’identità e vieni inghiottito da un vuoto a cui non si è più abituati. Non si può mandare un Whatsapp a nessuno, nè aprire una mappa o vedere anche solo che ora è: quando sei lì ti spogli delle tue abitudini e questo ti amplifica alcune percezioni
L’ultima domanda voglio fartela sul tuo prossimo lavoro, Cosa Rimane Quando il Mare si Muove: a che punto sei della lavorazione?
Ho presentato il film all’Industry del Festival dei Popoli dove ha vinto il bando della sezione Proxima, riservato a film documentari in fase di montaggio e post-produzione. Siamo adesso al mix del suono, dovrebbe terminare il prossimo mese e spero di uscire nell’autunno, se non prima. Sarà un film scientifico ma anche sperimentale sull’impatto del turismo nelle zone costiere durante l’inverno. Mostrerà quindi questo lato b del turismo: gli stessi luoghi presi d’assalto in estate ma filmati in inverno, più precisamente da fine settembre a inizio giugno. Avrà diverse tipologie di materiale all’interno, dall’archivio alle riprese analogiche fino a videocamere di sorveglianza. Ho girato prevalentemente a Cagliari, nella spiaggia del Poetto, per dare l’idea che non è solo la grande città a “smontare” ma tutta l’isola, come se l’El Dorado del turismo dovesse far lavorare tutti costringendo chi resta in inverno ad aggiustare i pezzi di questa invasione di massa concentrata solo in due mesi
L’articolo Trieste Film Festival – Interview with Gaetano Crivaro for In the penal colony proviene da SentieriSelvaggi.